Il buco nero ‘mostruoso’ della Via Lattea ruota al limite della fisica
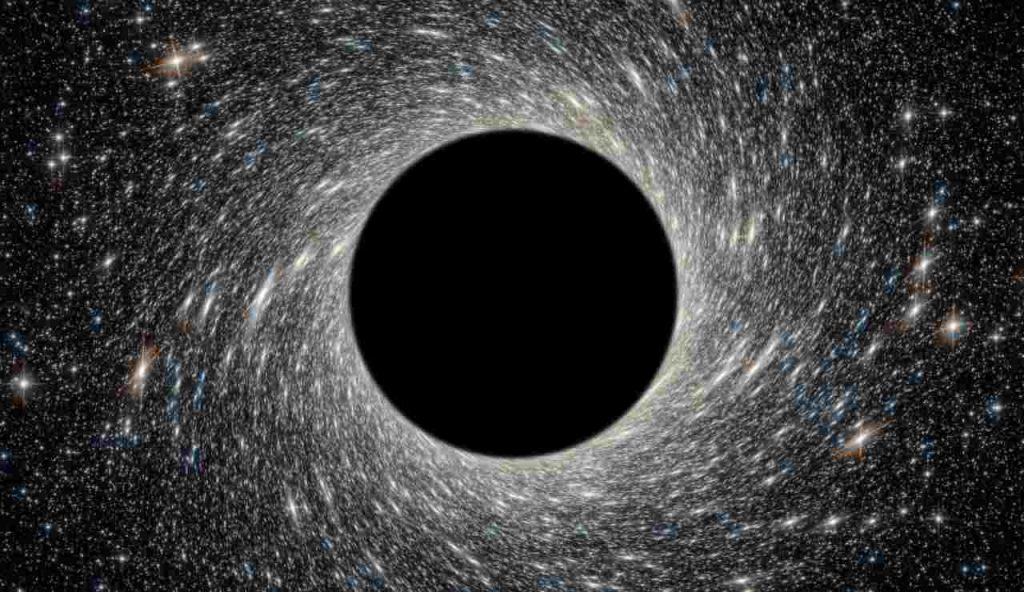
Illustrazione di un buco nero (Canva FOTO) - aerospacecue.it
Questo grandissimo buco nero è sorprendente, e possiede delle caratteristiche davvero uniche e si trova al centro della nostra Galassia.
Al centro della nostra galassia, nascosto tra miliardi di stelle, si trova un vero colosso cosmico: Sagittarius A* (o Sgr A*), il buco nero supermassiccio della Via Lattea. Ed è appena stato confermato che questo gigante sta ruotando quasi al massimo della velocità teoricamente consentita dalle leggi della fisica.
Questo dettaglio notevole è emerso grazie a un nuovo approccio sviluppato da un gruppo di ricercatori guidato da Michael Janssen, dell’Università Radboud nei Paesi Bassi e del Max Planck Institute for Radio Astronomy. Il team ha lavorato con i dati raccolti dall’Event Horizon Telescope (EHT), lo stesso consorzio che aveva già ottenuto le prime immagini dirette dell’ombra di un buco nero: prima M87*, e poi il nostro Sgr A*.
Ora, è vero che quelle immagini hanno fatto la storia, ma non sono semplici da interpretare. Servono simulazioni sofisticate, modelli teorici complessi e, soprattutto, tanta potenza di calcolo. E qui entra in gioco una novità: l’uso di reti neurali addestrate su milioni di dati simulati, in grado di estrarre ogni minimo indizio fisico sepolto nei dati osservativi.
Tra i risultati più sorprendenti: non solo la rotazione vertiginosa di Sgr A*, ma anche l’orientamento del suo asse di rotazione, che sembra puntare proprio verso la Terra. E, forse ancora più interessante, un comportamento “particolare” dei campi magnetici.
Una nuova generazione di simulazioni
Il gruppo di Janssen ha creato una vera e propria libreria di buchi neri virtuali: quasi un milione di simulazioni basate su modelli di magnetoidrodinamica relativistica generale (GRMHD, per gli addetti ai lavori), che tengono conto di variabili come spin, inclinazione e stato del disco di accrescimento. Per ogni configurazione, è stata calcolata l’emissione elettromagnetica che l’EHT potrebbe registrare, tenendo conto anche delle complicazioni tecniche reali come il rumore di fondo e gli errori di calibrazione. Con questi dati in mano, è stata addestrata una rete neurale bayesiana attraverso una piattaforma chiamata ZINGULARITY, descritta nei tre articoli pubblicati su Astronomy & Astrophysics (vol. 698, articoli A60, A61, A62).
La rete è stata addestrata su dataset sintetici che riproducevano fedelmente le osservazioni reali dell’EHT del 2017. Risultato? Un modello in grado di stimare con grande precisione parametri fisici fondamentali come la velocità di rotazione del buco nero, l’inclinazione del disco e persino il tipo di flusso magnetico. Secondo le analisi, Sgr A* ruota con uno spin tra 0,8 e 0,9 (dove 1 è il massimo teorico), con un flusso di accrescimento prograde, cioè che gira nello stesso senso della rotazione del buco nero. L’asse di rotazione sembra inclinato di circa 20–40° rispetto alla linea di vista terrestre. Non solo: l’emissione luminosa intorno a Sgr A* è prodotta da elettroni molto energetici, e i campi magnetici nei dintorni non si comportano come previsto.

Altri dettagli molto interessanti
Lo stesso approccio è stato applicato anche a M87*, l’altro celebre buco nero osservato dall’EHT. Qui, però, la storia è un po’ diversa: lo spin stimato va da 0,5 a 0,94, ma ruota in direzione opposta rispetto al disco di accrescimento. Questo disallineamento potrebbe essere il risultato di una fusione passata con un altro buco nero supermassiccio.Un aspetto particolarmente interessante è che, grazie a ZINGULARITY, le incertezze nelle stime dei parametri si sono ridotte in modo significativo, anche in presenza di problemi come le schermature di Faraday (che distorcono il segnale radio lungo la linea di vista) e difetti di calibrazione.
Secondo gli autori, come riportato da Science Alert, l’arrivo di nuovi telescopi nel network dell’EHT, come l’Africa Millimeter Telescope attualmente in costruzione, potrebbe migliorare ulteriormente la precisione fino a tre volte per i modelli non-Kerr, ovvero quelli che mettono alla prova la relatività generale. In sostanza, queste analisi rappresentano un punto di svolta. I risultati su Sgr A* e M87* non solo si accordano con altre osservazioni su più lunghezze d’onda, ma permettono anche di restringere i modelli teorici a disposizione. E aprono la strada a una nuova generazione di simulazioni GRMHD, create appositamente con i parametri interpolati dai dati reali.
