Scoperto un buco nero di massa intermedia: la rara “taglia” che mancava all’Universo
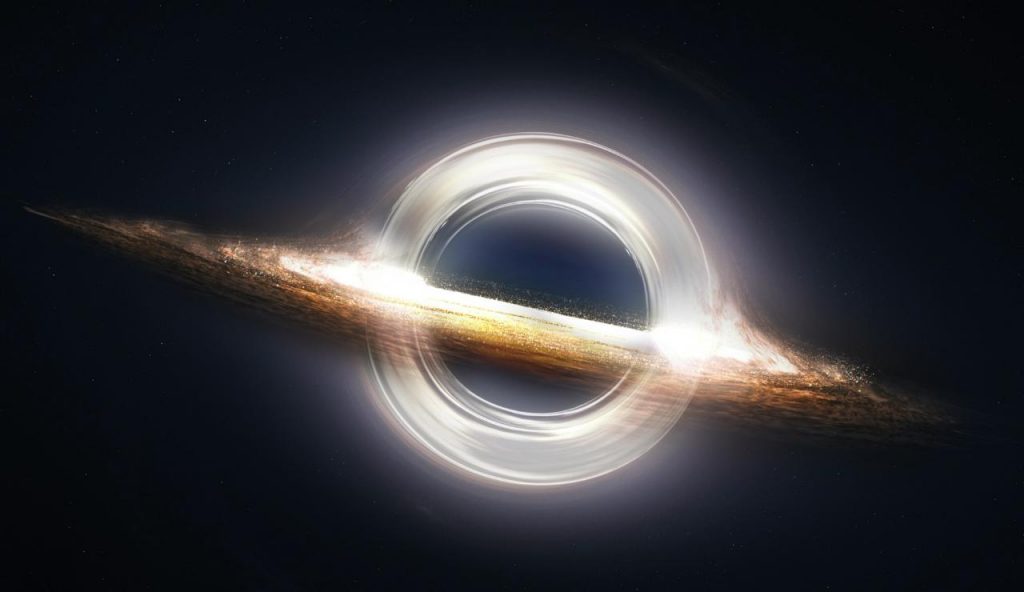
Buco nero nello spazio (Canva foto) - www.aerospacecue.it
Questo buco nero appena scoperto è molto interessante, ed è caratterizzato da una massa intermedia. Una taglia un po’…rara!
Certe volte l’Universo sembra divertirsi a lasciare indizi sparsi, come se volesse vedere quanto ci mettiamo a collegarli. È il caso di una sorgente X, puntiforme e insolitamente luminosa, scovata ai confini della galassia ellittica NGC 6099, a circa 139 milioni di parsec. Gli archivi di XMM-Newton e Chandra mostrano che la sua intensità non è costante: nel 2012 ha toccato un picco di luminosità X stimato in alcune volte 10⁴² erg/s, mentre nel 2009 e nel 2023 è stata circa 50–100 volte più debole.
Quello che colpisce non è solo l’energia sprigionata, ma anche lo spettro: sempre “morbido”, con una componente termica attorno a 0,2 keV e un indice di potenza superiore a 3. Segni che fanno pensare a un buco nero di massa intermedia (IMBH) vicino o oltre il limite di Eddington, anche se non è l’unica spiegazione possibile. La natura della sorgente resta ambigua, con ipotesi che vanno dal fenomeno di distruzione mareale (TDE) fino a un nucleo attivo lontano che cambia aspetto.
Le immagini del Canada–France–Hawaii Telescope e poi del Hubble Space Telescope hanno rivelato un minuscolo punto blu in corrispondenza della sorgente X. La sua luminosità ottica (circa 24,7 mag in banda g) e i colori fanno pensare a un ammasso stellare compatto o a un disco di accrescimento illuminato dai raggi X.
In assenza di misure ottiche simultanee alle osservazioni X e senza uno spostamento verso il rosso confermato, è difficile stabilire con precisione la distanza e la natura dell’oggetto. Tuttavia, la sua compattezza ottica e la luminosità estrema favoriscono lo scenario dell’IMBH legato a un ammasso stellare nell’alone di NGC 6099, piuttosto che quello di una galassia attiva molto lontana.
Analisi dei dati Capire
che cosa sia davvero accaduto non è semplice, perché i segnali osservati possono essere interpretati in modi diversi. Tra le ipotesi più convincenti c’è quella che coinvolge un buco nero di massa intermedia (IMBH), un oggetto raro e affascinante, con una massa di migliaia di volte quella del Sole. Secondo questa lettura, gli episodi del 2009 e del 2023 sarebbero stati fasi tranquille, con luminosità relativamente bassa, mentre nel 2012 si sarebbe verificato un vero e proprio picco energetico. I dati spettroscopici e i modelli di disco di accrescimento sembrano effettivamente indicare un raggio interno compatibile con un buco nero di questo tipo.
Per spiegare il comportamento osservato sono state proposte diverse possibilità. Una riguarda i cosiddetti cicli di instabilità del disco, fenomeni che in altri sistemi si sviluppano in tempi più brevi, ma che qui potrebbero durare secoli. Un’altra ipotesi è quella dell’alimentazione episodica, in cui una stella in orbita eccentrica cede parte della propria massa ogni volta che passa troppo vicina al buco nero. Questo schema, già suggerito per l’oggetto ESO 243-49 HLX-1, renderebbe comprensibile l’outburst del 2012, seguito da fasi più deboli.
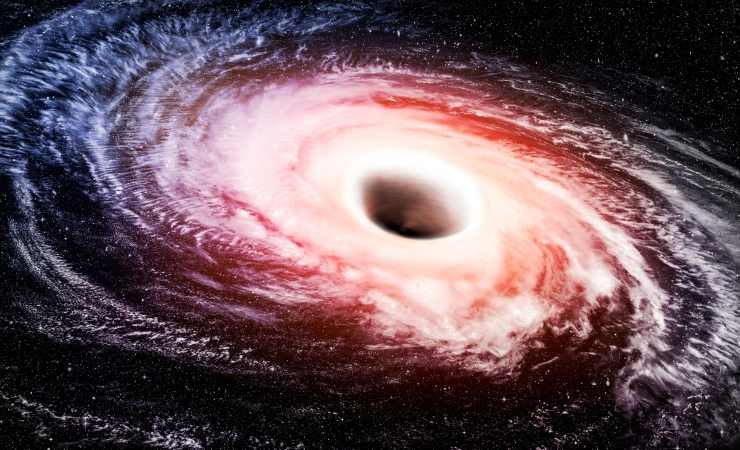
Conclusioni e scenari alternativi
Non mancano comunque teorie diverse. Alcuni studiosi hanno ipotizzato un evento di distruzione mareale (TDE), cioè quando una stella viene smembrata dal campo gravitazionale del buco nero. In questa ricostruzione, il 2009 sarebbe stato dominato da emissione ottica e ultravioletta causata dagli urti tra i detriti stellari, mentre nel 2012 si sarebbe formato il disco di accrescimento, responsabile della brillante emissione nei raggi X. Tuttavia, i dati raccolti dal Palomar Transient Factory tra il 2009 e il 2013 non mostrano segni di un involucro otticamente luminoso, un dettaglio che rende questa ipotesi meno solida. Esistono comunque esempi di TDE “lenti”, come ASASSN-15oi o EP240222a, che hanno mostrato un’evoluzione simile.
È stata anche esclusa, con buona sicurezza, l’ipotesi di un AGN di fondo, poiché a grandi distanze la luminosità avrebbe superato valori estremi, oltre 10⁴⁶ erg/s. Rimane quindi l’interpretazione più plausibile: quella di un buco nero di massa intermedia situato in un ammasso stellare compatto o in una galassia nana ultra-compatta (UCD). In questo quadro, la luce ottica blu osservata deriverebbe soprattutto dal disco irradiato, mentre la componente più debole e rossastra proverrebbe dall’ammasso stesso (cfr. Palomar Transient Factory; ESO 243-49 HLX-1).
